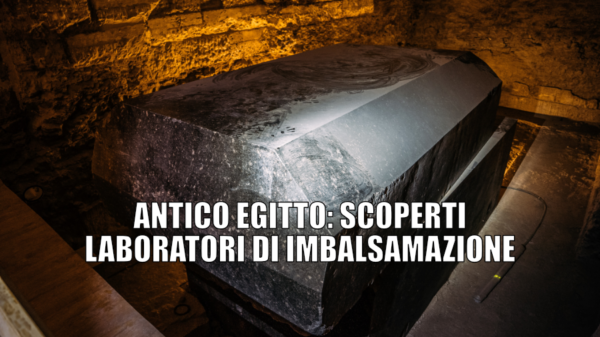PROLOGO – Campo de’ Fiori, Roma, tarda sera
Scena aperta:
Una sera romana, leggera foschia, qualche turista distratto, il rumore delle stoviglie da una trattoria lontana.
Al centro della scena — la statua di Giordano Bruno a Campo de’ Fiori, oscura e imponente.
Dietro, il palazzo della Cancelleria e la cupola di Sant’Agnese.
A pochi passi, sotto la luce gialla di un lampione, si ritrovano Giorgio, trentenne dall’aria sveglia e ironica, e il suo vecchio professore di liceo, Lapenna, giacca stropicciata, sguardo stanco ma acceso.
Giorgio
(guardando la statua con un sorriso storto)
Professor Lapenna…
ma guarda un po’ chi si rivede.
Che ci fa qui? In pellegrinaggio?
Prof. Lapenna
(con tono ironico)
Più che pellegrinaggio, direi… naufragio quotidiano.
Cammino spesso qui la sera. Mi fa bene sentirmi giudicato da uno che ha fatto la fine del rogo.
Giorgio
(alzando lo sguardo verso la statua)
Eh già.
Giordano Bruno.
Il filosofo “eretico”, il martire della libertà…
o solo un cialtrone che credeva di sapere tutto?
Prof. Lapenna
(sospirando)
Dipende da chi racconta la storia.
Sai che, quando posero questa statua, nel 1889, il papa minacciò di lasciare Roma se non l’avessero rimossa?
Giorgio
(sorpreso)
Sul serio?
Prof. Lapenna
Serissimo. Leone XIII, in persona.
Perché la statua la volevano i massoni, i laici, i liberali, quelli del “libero pensiero”.
La eressero proprio dove Bruno fu bruciato.
Una sfida, bella e buona.
Una provocazione in bronzo.
Giorgio
(mordace)
E Bruno, dall’alto, se la gode.
Alla faccia del papa, dei cardinali… e forse anche della verità.
Pausa. I due restano in silenzio, fissando la statua.
Poi Giorgio strizza gli occhi, punta verso una stradina laterale.
Giorgio
(vivace)
Professor Lapenna… ma invece di filosofeggiare sotto il cappuccio dell’eretico, che ne dice se andiamo a farci un bicchiere?
C’è una bettola a due passi, fa schifo… ma è sincera.
Prof. Lapenna
(ridacchia)
Una bettola?
Perfetto.
Bruno avrebbe approvato.
Lui preferiva i bordelli alle biblioteche, a quanto pare.
Escono di scena, addentrandosi in una viuzza che sbuca su una piccola osteria mezza vuota.
La luce cambia: entra calore, vino, parole.
Il dialogo vero comincia qui.
Giorgio: Grazie per la domanda super interessante, professor Lapenna. Però, su una cosa non sono affatto d’accordo. Mi sembra che tu stia cercando di difendere Giordano Bruno, ma non possiamo dimenticare che Bruno ha preso tre scomuniche. Tre! Da tutte le confessioni principali: i cattolici, i calvinisti, e persino gli anglicani. E tutto per le sue teorie che sono davvero, come dire… fuori dal comune. Non era solo un filosofo che cercava la verità, ma un uomo che ha sfidato ogni autorità e ha spinto a un relativismo che per me è pericoloso.
Francesco Lapenna: Ah, Giorgio, Giorgio, ti concedo che Bruno fosse un personaggio complesso e che la sua condanna dalle autorità ecclesiastiche non fosse un episodio da sottovalutare, ma non possiamo ridurlo a un “eretico pericoloso”. Non è così semplice. Quando Bruno viene scomunicato, non è solo per le sue idee cosmologiche, ma perché il suo pensiero metteva in crisi la stessa concezione di autorità che la Chiesa aveva allora. Bruno era un uomo che rifiutava ogni dogma, e questo lo rendeva un outsider. Ma la sua sfida al potere non era mai gratuita, come nel caso di Bonifacio in Il Candelaio, che è un altro esempio di illusione. Bonifacio cerca l’impossibile, proprio come la Chiesa tentava di manipolare il concetto di verità.
Giorgio: Sì, ma non possiamo ignorare il fatto che Bruno, pur essendo un pensatore brillante, rifiutava ogni autorità, anche quella della ragione. Mi sembra che alla fine il suo pensiero si riduca a una continua ricerca di un’illuminazione personale che porta alla disperazione. Se guardiamo Il Candelaio, non possiamo evitare di notare la sua critica nei confronti della società, ma anche del comportamento umano, della vanità, e dell’avarizia. Non c’è una via di salvezza universale, come vuole farci credere. È un mondo di inganni e illusioni, che lui sembra voler esaltare. Non è un messaggio che possiamo accettare facilmente, soprattutto in un contesto cristiano come il mio.
Francesco Lapenna: È interessante che tu parli di “via di salvezza”, Giorgio, perché in fondo Bruno non ha mai proposto un “salvatore” tradizionale, ma un cammino di consapevolezza. Non ti nego che il suo pensiero può apparire radicale, ma non è mai relativista nel senso che intendi tu. Bruno ci parla della possibilità di salvarci attraverso la conoscenza, ma una conoscenza che è illuminante, che ci porta a vedere il divino in ogni cosa. La critica che Bruno fa in Il Candelaio non è un invito a cedere alle illusioni, ma un monito contro chi vive nell’inganno. Bonifacio, l’avaro, è l’emblema di chi non capisce il valore del reale, di chi è accecato da desideri irraggiungibili e da sogni di grandezza. Non vedo nulla di “pericoloso” nel tentativo di Bruno di farci riflettere su queste illusorie ambizioni.
Giorgio: Ma come possiamo ignorare la sua visione così… individualistica? Bruno si scaglia contro la Chiesa, ma anche contro la stessa umanità, cercando di separare il sacro dal profano, mettendo a repentaglio quel tessuto di comunità e fede che invece è fondamentale per la nostra crescita come popolo cristiano. Quello che mi lascia perplesso è come riesci a vedere Bruno come una figura di “salvezza”. Mi sembra che non ci sia una vera redenzione nelle sue teorie, ma solo una continua tensione verso qualcosa di astratto e distante dalla realtà.
Francesco Lapenna: Ti capisco, Giorgio. Il tuo punto è legittimo, ma forse non stai cogliendo l’essenza di Bruno. Bruno non ha mai voluto separare il sacro dal profano; anzi, per lui tutto l’universo è permeato dal divino. La sua sfida al dogma ecclesiastico non è un invito all’individualismo, ma piuttosto una proposta di un nuovo modo di vedere il mondo. Bruno voleva liberarci dalle catene di una fede cieca per offrirci una visione più alta, in cui l’uomo è in grado di partecipare attivamente alla creazione del mondo attraverso la conoscenza. Questo è il cuore del suo pensiero, anche in Il Candelaio: non è una critica per il gusto della critica, ma un invito a guardare al mondo con occhi più profondi.
Giorgio: Ma non ti sembra che Bruno, nel suo rifiutare ogni forma di autorità, abbia finito per cadere in un’auto-illusione? Alla fine, se tutti sono liberi di interpretare la verità a modo loro, la verità stessa perde il suo significato. E la realtà che ci propone è una realtà senza equilibrio. Mi sembra che la sua ricerca della verità sia infinita e, in un certo senso, senza meta.
Francesco Lapenna: Ti rispondo così, Giorgio, Bruno non intendeva dire che ogni interpretazione della verità fosse uguale. Semmai, la sua sfida era contro un’interpretazione della verità che era imposta dall’alto, che non rispettava la capacità individuale di arrivare a una comprensione più profonda del divino. Per lui, la verità non era un dogma, ma un percorso. La sua visione era universale, ma non individualista nel senso che intendi tu. Quello che voleva dirci è che la nostra ricerca della verità è una ricerca collettiva, che passa attraverso la nostra crescita personale, ma che implica anche una maggiore comprensione reciproca, una fede non nella Chiesa come istituzione, ma nella capacità dell’uomo di elevarsi.
Giorgio: Eppure, nella sua ricerca della verità, Bruno ha finito per creare più divisione che unione. Le sue idee non sono mai riuscite a essere accettate da nessuna delle grandi fedi, eppure lui continuava a proclamare la sua verità assoluta. Alla fine, come puoi dire che il suo pensiero non fosse arrogante?
Francesco Lapenna: Ah, ma qui entriamo in un terreno pericoloso, Giorgio! La storia di Giordano Bruno non è una storia di trionfo personale, ma di fallimento di una concezione chiusa di verità. Bruno era sì arrogante, e il suo pensiero sicuramente non era facile da digerire per l’epoca. Ma non possiamo misurarlo con i criteri della nostra modernità. Quello che lui ha cercato di fare è stato sfidare l’idea che la verità fosse già scritta e che non dovessimo fare altro che obbedire. Se qualcuno, alla fine, si è trovato più in sintonia con la sua visione, è stato un dono. Se non altro, ci ha dato un esempio di chi non ha paura di porsi domande, di mettere in discussione ogni certezza. E questo, Giorgio, è il cuore del pensiero libero.
Giorgio: D’accordo, ma come posso accettare un pensiero che non riconosce mai l’umiltà di mettersi in discussione?
Francesco Lapenna: Ah, ma la sua sfida non era mai quella dell’orgoglio, Giorgio. Era la sfida di chi si rende conto che, spesso, per raggiungere una verità più alta bisogna attraversare il fuoco delle proprie certezze. E, forse, il vero punto non è se Bruno avesse ragione o meno, ma che ci abbia spinto a cercare la nostra verità, a non accontentarci delle risposte facili. E questa, secondo me, è una delle ragioni per cui ancora oggi parliamo di lui.
Giorgio: Forse, professor Lapenna, la verità non è mai così semplice come vogliamo che sia. Ma alla fine, come diceva qualcuno, «è solo nella ricerca che troveremo la risposta».
Francesco Lapenna: Ecco, Giorgio, direi che questa frase riassume perfettamente la lezione di Bruno. Nulla di più, nulla di meno.
Giorgio
(versando un filo di vino nel bicchiere del professore)
Allora, caro Lapenna, lo ammettiamo finalmente? Quelle “lettere rotonde” nel Candelaio sono monete, denaro, sonanti! Altro che poesia o grazia stilistica… E Bruno non stava lì a condannare, ma a ridere. Con cattiveria.
Prof. Lapenna
(ridacchia, stringendo il calice)
E tu pensi che riderne significhi essere d’accordo? Bruno si diverte come un chirurgo che affonda il bisturi: ride per non piangere. È una satira feroce, sì — ma è anche una chiamata al risveglio.
Giorgio
Una chiamata al risveglio? In mezzo a candele, doppi sensi fallici e accademici rimbambiti? Mi pare più un cabaret filosofico che un manifesto spirituale.
Prof. Lapenna
(mordace)
Eppure è proprio lì che Bruno è più lucido. Perché non redime nessuno, Giorgio. Non ti dà conforto. Ti sbatte in faccia l’abisso: o hai giudizio, o sei carne da truffa. E il fatto che “le donne vogliano lettere rotonde” lo capiscono tutti… tranne i pedanti, gli idealisti e gli innamorati.
Giorgio
Ecco, appunto, tranne i credenti. Perché nel mondo di Bruno, se Dio è ovunque, allora è anche nelle prostitute, nelle truffe, nel fango, nell’inganno. E scusami se lo dico — ma questo non è Dio. Questo, se permetti, sembra più… Satana.
Prof. Lapenna
(alza un sopracciglio, accende la pipa)
Ah, eccoci. La solita confusione cristiana, tutto ciò che è immanente deve essere diabolico. Ma no, caro mio. È che la tua religione ha un problema con il corpo. Bruno no. Bruno ama la materia, la trasfigurazione, il moto eterno delle cose. Il suo Dio non è un vecchio nei cieli, è la forza che muove i mondi.
Giorgio
…che però è caduto sulla terra. Non sei tu che citavi Lucifero a lezione? L’angelo che voleva essere “come Dio” e per questo fu scagliato giù? Bruno mi pare più vicino a quell’archetipo che al Cristo del Vangelo.
Prof. Lapenna
(sbuffa fumo, quasi divertito)
E allora? Anche Prometeo fu punito per aver dato il fuoco agli uomini. Eppure, lo veneriamo. Bruno non è Satana. È colui che dice: “Dio è nel fiore che marcisce, nella stella che esplode, nel pensiero che osa”. Ti sembra poco?
Giorgio
Mi sembra un filosofo senza grazia. Uno che ha scomunicato tutto Roma, Ginevra, l’Inghilterra. Tre volte espulso, mai amato. Forse perché a forza di voler essere “libero”, è finito prigioniero di sé stesso.
Prof. Lapenna
(sottile, graffiante)
Oppure perché non voleva padroni. Né Dio né Cesare. E ti dirò di più, chi lo chiama eretico lo fa per paura. Perché Bruno non accetta mediazioni, né dogmi né altari. Vuole che ogni uomo sia filosofo.
Giorgio
Ma se ogni uomo è filosofo, nessuno lo è davvero. Bruno pretende che tutti pensino — ma a modo suo. È un despota della libertà, se mi passi l’ossimoro.
Prof. Lapenna
(sorridendo con malizia)
Oh, te la passo eccome. Perché hai colto il punto. Bruno non è un santo, né un profeta. È una forza. Una scintilla. E chi la prende, rischia di bruciarsi. Ma chi la evita, resta al buio.
(A quel punto, intervenni io… ma solo nel pensiero)
Ero rimasto in silenzio per tutto il tempo, seduto a un tavolo poco distante, con la mia amica che ascoltava, affascinata e confusa.
Fingevo di leggere il menù, ma annotavo di nascosto su un tovagliolo le parole chiave che volavano come coltelli sopra i bicchieri mezzi vuoti:
“Lettere rotonde”…
“Dio immanente”…
“Lucifero, Prometeo, Gnosis”…
Sembrava una disputa teologica rubata al Medioevo, ma trasportata per sbaglio in una bettola del XXI secolo — tra vino rosso, lampadine a luce calda e il profumo di carbonara.
Lapenna, stanco ma incandescente.
Giorgio, pungente e lucido come un bisturi.
Due fuochi opposti, ma nati dalla stessa scintilla: la fame di verità.
Quando sollevai il bicchiere, mi accorsi che nessuno dei due aveva davvero vinto.
Anzi.
Erano come le due facce di una stessa medaglia:
la medaglia di chi cerca la verità a qualsiasi costo, anche a rischio di bruciarsi le dita o l’anima.
E forse, ecco il punto.
Giordano Bruno non è affascinante perché ha vinto o perso.
È affascinante perché ci costringe, ancora oggi, a guardare dentro di noi.
Oltre le risposte facili.
Oltre i dogmi.
Oltre i travestimenti della verità.
Forse il rogo non lo ha mai bruciato davvero.
Ci ha solo lasciato accesa la miccia.
Giorgio:
(Con un sorriso sardonico)
Ma davvero credi che Giordano Bruno fosse solo un “misterioso poeta del libero pensiero”? Diciamocelo: se dovessimo metterlo in una casella, non sarebbe quella del martire del pensiero libero. Piuttosto, Bruno è l’alchimista del pensiero, l’uomo che ha trasformato la religione in una chimica dell’anima! Non cerca il salvataggio dell’anima attraverso la grazia di Dio. No, lui vedeva la divinità come cosmica, l’universo stesso, e ogni angolo di questo mondo materiale è pieno di divinità. Il che, ti dirò, lo rende piuttosto simile a un portatore di luce.
Il Professore:
(Scuotendo la testa, quasi divertito dalla passione di Giorgio)
Già, ma la luce di Bruno, mio caro, non è quella di un santo o di un profeta, ma quella di un mago. Lo sai che la Chiesa cattolica lo scomunicò non solo per le sue teorie cosmologiche, ma perché le sue visioni sfidavano direttamente la dottrina dell’anima e della salvezza. Bruno, con la sua gnosi e alchimia, voleva fare dell’uomo un Dio minore, capace di risolvere ogni enigma dell’universo senza il bisogno di grazia divina o intermediari come la Chiesa. Questo non è l’uomo libero, è il cammino verso il disastro spirituale!
Giorgio:
(Accigliato, come se stesse cercando di forzare un ragionamento che il Professore non vuole accettare)
Ma forse il vero disastro spirituale è quella “divinità trascendente” che avete creato voi, professori e teologi. È un Dio che è solo al di fuori di noi, che non ha niente a che fare con la terra e l’uomo. Bruno, al contrario, abbraccia l’infinito, l’universo come un Dio immanente, che non ha bisogno di troni, ma di cervelli curiosi. Non ha paura dell’uomo che indaga, perché l’uomo è il riflesso dell’infinito stesso. Non è l’umile creatura. È un microcosmo in grado di capire il macrocosmo!
Il Professore (divertito): Si.
Giorgio:
(Con tono sarcastico)
Quindi, secondo te, l’uomo è il piccolo Dio che deve svelare i segreti dell’universo? La sua presunzione è diventata una religione? Ma che cosa dobbiamo fare con i pompieri di queste visioni? Giordano Bruno non è un illuminato. È un presuntuoso che, credendo di avere la verità, ha scagliato tutto e tutti nel fuoco del suo ego. Hai idea di quanti uomini del suo tempo abbiano condannato la sua follia? Persino i suoi compagni di fede, come il domenicano che era, hanno dovuto distaccarsi da lui!
(A questo punto, alzo il bicchiere con calma, guardando i due mentre si avvolgono in una spirale di argomentazioni)
Io (pensando):
(Accenno un sorriso mentre scrivo rapidamente sul tovagliolo, ma resto in silenzio, sentendo la tensione crescere tra i due. Non voglio interrompere. So che in realtà non si tratta di Bruno, ma di loro due. Un gioco di maschere e ruoli che si riflette nella ricerca della verità… o forse del potere.)
il Professore (guardando Giorgio con un sorriso provocatorio):
(Indica verso la statua di Giordano Bruno nella piazza)
Guarda quella statua. È lì che Giordano Bruno ha vinto. E non ha vinto contro la Chiesa, o contro la ragione di chi lo ha condannato, ma ha vinto contro l’idea che l’uomo debba piegarsi, debba accettare il buio. Il fuoco della conoscenza non è mai stato spento. Lui è Lucifero, non nel senso maligno, ma come portatore di luce.
Giorgio:
(Indica la statua con un movimento ampio della mano, quasi come se volesse scacciare la figura da lui)
Quella statua è un simbolo dell’orgoglio umano, che si crede superiore a Dio, superiore alla Chiesa, superiore alla storia. Bruno era un mago del caos, e quei suoi libri, quei suoi scritti, sono la prova di quanto fosse disposto a sfidare l’ordine divino per dare spazio alla sua follia. Gli uomini che credono di vedere la luce da soli finiscono per essere accecati dalla loro stessa presunzione. La verità, Professore, non è nelle fiamme del sapere cieco, ma nella lucida umiltà dell’anima che sa di essere, prima di tutto, creatura di Dio.
Io (finalmente interrompendo, ma senza alzare la voce):
(Mi volto verso i due, notando che entrambi mi fissano, forse aspettandosi che io prenda una posizione. Ma so che è il momento giusto per dire solo una cosa, una cosa che li metta faccia a faccia con la loro stessa contraddizione).
“Avete più paura voi a condannarmi che io ad essere condannato.”
(Un silenzio calato tra noi, mentre lo sguardo di entrambi si sposta verso di me, come se quella frase toccasse un punto delicato. Non serve altro. La conversazione si spegne, ma le loro espressioni restano intense, ancora intrappolate nel pensiero che si riversa su Giordano Bruno.)
Giorgio
(incrocia le braccia, con un mezzo sorriso)
Ma allora, professore… Bruno è “divino” o è “dannato”? Perché io qui ci vedo un cortocircuito bello grosso.
Prof. Lapenna
(sorride, scuotendo il capo)
Dipende da chi guarda, Giorgio. Per la teologia cristiana ortodossa, Bruno è un pericolo pubblico: confonde Dio e mondo, cielo e materia… e quindi, per chi ama le etichette, può sembrare addirittura “satanico” — nel senso simbolico del termine, eh.
Giorgio
Simbolico o no, la sostanza è chiara. Se dici che Dio è nella carne, nella terra, nel desiderio, nella putrefazione… per il catechismo non sei un mistico. Sei un eretico. O peggio, un illuso che ha scambiato l’Inferno per il Paradiso.
Prof. Lapenna
O un visionario che ha visto il divino dove nessuno voleva guardare. Bruno non è un adoratore della materia. È uno che la onora, perché la capisce. Per lui non esiste il “male assoluto”, solo trasformazione. L’universo è un campo di energia in perenne metamorfosi. E in questo fluire, tutto è sacro.
Giorgio
Ma allora dove sta il peccato? Dove sta il male? Se tutto è sacro, niente lo è davvero. E senza un centro, tutto si disperde.
Prof. Lapenna
(diretto, con tono quasi paterno)
Il male esiste, ma non come sostanza. È ignoranza, è chiusura mentale, è illusione. È il rifiuto del divenire. Bruno non nega il dolore, nega che sia eterno. Per lui non c’è peccato originale, solo un’enorme incomprensione originaria.
Giorgio
E l’anima? Per la Chiesa è immortale, unica, voluta da Dio. Per Bruno sembra solo una scintilla destinata a rientrare nel tutto. Una goccia nel mare. E mi scusi… (Giorgio passa al lei verso il Professore), ma se io sono solo una goccia, che senso ha vivere? O morire?
Prof. Lapenna
Perché proprio in quella goccia c’è l’infinito. Bruno non distrugge l’individuo, lo libera dalla paura. Niente dannazione eterna, niente giudizio finale, solo il ritorno alla sorgente. E non è forse più consolante sapere che non finiamo in un tribunale celeste, ma in un abbraccio cosmico?
Giorgio
(con sarcasmo)
Se però l’abbraccio cosmico è lo stesso che riceve un fiore, un lombrico o una pietra… che dignità resta all’uomo? Che senso ha la coscienza?
Prof. Lapenna
(riflette un attimo, poi risponde con calma)
La coscienza è il miracolo. È il fuoco interiore. Ma non ti rende superiore, ti rende responsabile. Bruno non ti eleva al trono, ti mette in mezzo all’universo — non come padrone, ma come fratello di tutte le cose. E non è meno sacro, è solo più umile.
Giorgio
O più disperato. Perché, se l’anima non ha salvezza, se non c’è un Cristo, un Redentore… allora siamo davvero soli.
Prof. Lapenna
(sguardo intenso)
Soli? No. Liberi. E non mi pare una brutta notizia.
(Intermezzo: voce fuori campo)
Io, intanto, ascoltavo trattenendo il respiro. Non era solo una discussione filosofica, era un duello tra due visioni del mondo. Una con Dio sopra, l’altra con Dio dentro.
E nel mezzo, noi, piccoli esseri umani assetati di senso, oscillanti tra la salvezza e la dissoluzione.
Giorgio
(fissa il professore, voce più bassa, ritornando al lei come al liceo)
Professore… e se le dicessi che Bruno oggi lo vedono quasi come un santo laico? Un modello per massoni, liberi pensatori, scienziati, mistici, new age. Tutti a venerare il filosofo che non si è inginocchiato. Ma…
(pausa)
…non sarà anche questa una forma di idolatria? Cambia solo il tempio.
Prof. Lapenna
(sorride amaramente)
Bravo, Giorgio. Stai arrivando al cuore. Vedi, Bruno non cercava seguaci: cercava verità. E questo lo rende pericoloso in ogni epoca. Non è stato bruciato solo perché bestemmiava il dogma, ma perché offriva un’alternativa. Un’altra via alla conoscenza, non rivelata, ma conquistata.
Giorgio
(con tono provocatorio)
La gnosi, insomma. La salvezza attraverso il sapere. L’uomo che si fa dio, perché ha aperto gli occhi. Ma allora non è spiritualità: è orgoglio.
Prof. Lapenna
(alza un dito)
O forse è coraggio. Per Bruno, la ragione non è contro la fede, è la sua maturazione. Non si ribella per superbia, ma per fedeltà a un Dio che non si nasconde nei dogmi, ma si manifesta in ogni stella, in ogni mente pensante. E la gnosi… è solo un altro nome per il fuoco interiore. Quello che arde, ma illumina.
Giorgio
(brusco)
Ma lei lo sa che molti massoni lo venerano? C’è persino chi lo chiama “maestro della luce”. Maestra la gnosi, maestra l’intelligenza umana… e Dio? Non pervenuto. O sostituito.
Prof. Lapenna
(con tono più serio)
Lo so bene. E non mi scandalizza. La Massoneria moderna ha fatto di Bruno un simbolo della libertà di coscienza. Ma attenzione, Giorgio, simbolo, non dogma. Bruno è stato adottato perché incarna un’idea: che l’uomo può cercare la verità senza pastori. Che non ha bisogno di inginocchiarsi per pensare.
Giorgio
(scettico)
Ma questo non è esattamente il peccato originale? L’uomo che vuole mangiare il frutto della conoscenza senza chiedere permesso?
Prof. Lapenna
(e ora il tono si fa dolce, quasi paterno)
Forse sì. O forse è l’uomo che finalmente cresce, smette di essere un bambino, e accetta il peso della libertà. Bruno non vuole spodestare Dio, vuole liberarlo dalla gabbia delle istituzioni. Non vuole distruggere la fede, vuole che nasca nuova, più vasta, cosmica.
Giorgio
E per questo ha pagato con il fuoco.
Prof. Lapenna
Sì. Ma non era il fuoco del rogo che lo spaventava. Era il buio dell’ignoranza, della sottomissione cieca. Bruno voleva accendere torce. E per farlo, si è fatto torcia lui stesso.
(Intermezzo narrativo)
Giorgio non risponde subito. Guarda fuori dalla finestra, dove un cielo cupo si apre lentamente al tramonto. Forse pensa a sé, forse pensa a quanto costa cercare la verità — e a quanti preferiscono vivere con gli occhi chiusi.
E Lapenna lo osserva in silenzio, come chi sa che la vera lezione è cominciata solo adesso.
Giorgio
(incalza, senza più rispetto reverenziale)
Allora, professore… ci risiamo. Ogni volta che parliamo di Bruno, si finisce sempre con la statua a Campo de’ Fiori, la fiaccola della libertà, il martire del pensiero.
Ma poi uno guarda i fatti, e cosa vede?
Un domenicano che sputava sulla Chiesa soltanto quando non era d’accordo. Uno che si faceva passare per iniziato, per filosofo magico… ma appena qualcuno lo contraddiceva, reagiva come un fanatico.
Prof. Lapenna
(trattiene un respiro, poi risponde con cautela)
Giorgio, capisco il tuo punto. Ma Bruno era un uomo del suo tempo, non nostro contemporaneo. Parlava un linguaggio che univa magia e metafisica, perché quella era la cultura del Rinascimento. Non puoi giudicarlo con la mentalità del XXI secolo.
Giorgio
(freddo, lucido)
E invece sì. Perché siete voi, voi professori, voi intellettuali, a volerlo attualizzare. Lo fate passare per precursore della scienza, della tolleranza, della libertà. Ma lui non era Galileo. Non cercava prove. Cercava potere sulla realtà.
E quando Oxford lo accusa di plagio… cosa fa? Fugge. Quando Ginevra lo critica… cosa fa? Insulta. A chiunque non lo adori, dà del cretino.
Prof. Lapenna
(voce incerta)
Non era un uomo facile… ma chi fa rivoluzione non può esserlo.
Giorgio
(ribatte secco)
No, professore. Non era rivoluzionario. Era totalitario — nel pensiero. Pretendeva di avere la verità in tasca. Scomunicato da tutti, non perché libero, ma perché intollerante. E la sua “religione”? Gnosi, alchimia, magia naturale… cioè, visioni esoteriche che escludono chi non è “iniziato”. Altro che libertà universale. Era un’élite spirituale — a immagine sua.
Prof. Lapenna
(si siede lentamente, quasi sconfitto)
Tu vedi solo l’ombra, Giorgio… ma Bruno parlava anche di luce.
Giorgio
(con tono più pacato, ma ancora affilato)
Sì. La sua luce. La sua visione. Unica, indiscutibile.
E se la Chiesa gli dava fastidio, era perché non era lui a guidarla.
Sa cosa penso, professore? Che Bruno non voleva liberare gli uomini dalla religione…
Voleva essere lui la nuova religione.
Prof. Lapenna
(abbassa gli occhi. La voce gli trema, per la prima volta)
Forse hai ragione.
(fa una pausa)
O forse… era solo un uomo troppo grande per essere accolto da un mondo ancora troppo piccolo.
Giorgio
(ma senza rabbia, quasi con tristezza)
O forse era un uomo troppo pieno di sé per accettare che anche gli altri potessero cercare Dio… in un altro modo. Ci rivedremo a Filippi!
Continua…
D. Malecogita